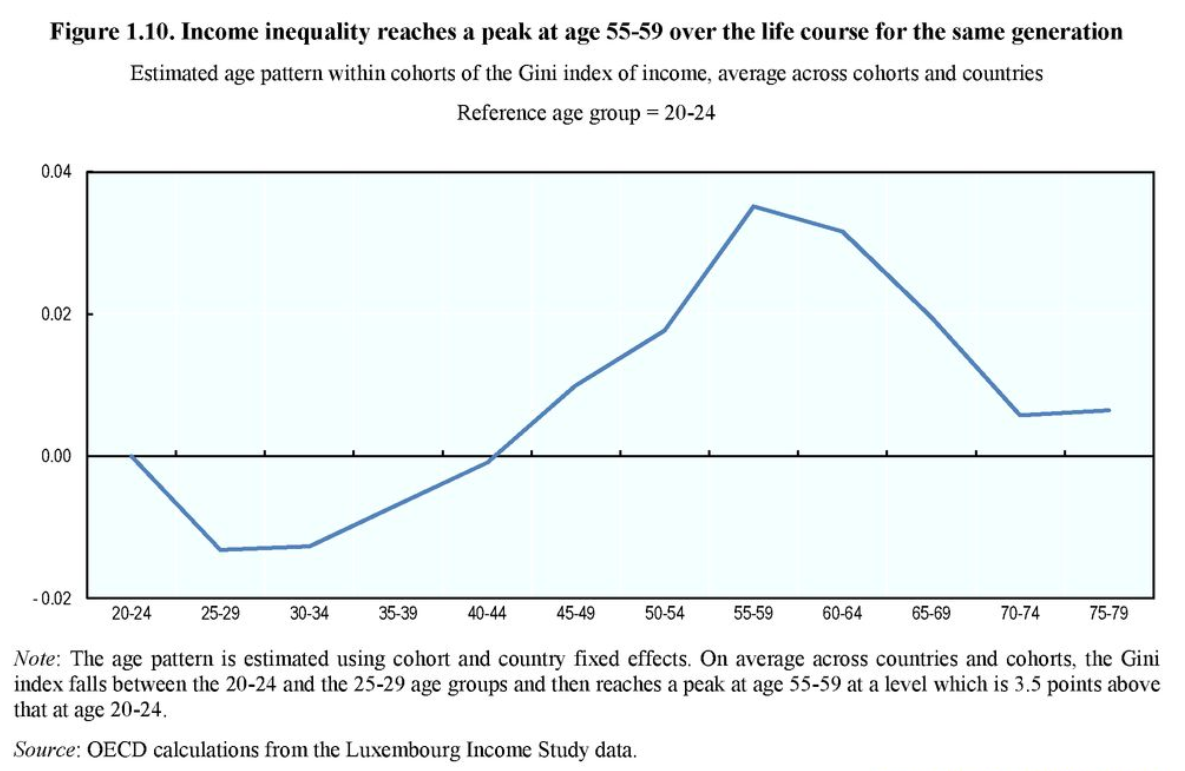Reblogged from L’Espresso
Mentre stiamo affacciati alle salde porte d’Europa con lo sguardo verso il Mediterraneo, sulla questione migranti e salute pubblica siamo soliti usare due pesi e due misure. Noi, gli autoctoni, in troppi casi, e contro le evidenze della medicina, ci sentiamo giustificati a sentirci esitanti di fronte all’opportunità di vaccinarci, a sollevare delle obiezioni, ma al tempo stesso siamo inflessibili con loro, gli immigrati, rei di riportare in Italia malattie che il nostro paese avrebbe debellato. Come se la responsabilità della stabilità della salute pubblica di un paese fosse oggi sbilanciata sullo straniero che arriva e non sulla comunità che lo accoglie.
Fortunatamente, i dati e i fatti dicono decisamente il contrario: i migranti non stanno minando in alcun modo la nostra salute.
Tutto origina da un preconcetto che ci portiamo dietro da decenni di migrazioni: quello secondo cui chi proviene da paesi più poveri di noi non sarebbe mai stato vaccinato contro le più comuni malattie: morbillo, tetano, rosolia, polio, tubercolosi. In realtà, i dati mostrano chiaramente che oggi le cose sono cambiate. I paesi del bacino del Mediterraneo, compresi quelli che fungono da transito nelle rotte migratorie verso l’Europa, offrono in media coperture vaccinali molto elevate alla propria popolazione, anche più alte di quelle italiane ( qui i dati ) e nella maggior parte dei casi offrono gratuitamente ai migranti in partenza o in transito verso l’Europa la maggior parte dei vaccini in commercio. Ai bambini, ma anche agli adolescenti e agli adulti.
Lo mette nero su bianco un rapporto pubblicato qualche settimana fa dall’Istituto Superiore di Sanità che raccoglie i risultati del progetto ProVacMed (“Programmes for Vaccination in the Mediterranean area”) che per la prima volta ha mappato l’offerta vaccinale in 15 paesi del Mediterraneo non appartenenti all’Unione Europea, sia nei confronti dei cittadini residenti, che dei migranti in entrata, che il più delle volte transitano per questi paesi con l’obiettivo di varcare le porte d’Europa. Tuttavia i paesi vicini dell’UE stanno diventando con maggior frequenza sempre più destinazioni a lungo termine o addirittura finali per un numero crescente di migranti misti.